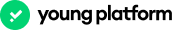È uscito il Consumer Price Index (CPI), il dato utilizzato per stimare l’inflazione negli Stati Uniti d’America.
È uscito il Consumer Price Index (CPI), il dato utilizzato per stimare l’inflazione negli Stati Uniti d’America. Il destino dei mercati passa dall’inflazione USA e, quindi, dal dato del Consumer Price Index (CPI) pubblicato il 13 febbraio. In questo articolo, scopriremo cos’è il CPI, perché è importante e analizzeremo gli ultimi dati disponibili.
CPI significato
Tecnicamente, il CPI (Consumer Price Index), o Indice dei Prezzi al Consumo, è un indicatore economico fondamentale che misura quanto sono cambiati i prezzi di beni e servizi che compriamo quotidianamente. In altre parole, il CPI ci dice quanto costa oggi vivere rispetto al passato.
Il CPI si calcola raccogliendo i dati sui prezzi di un “paniere” rappresentativo di beni e servizi che i consumatori solitamente acquistano. Questo paniere include una varietà di prodotti, come cibo, abbigliamento, alloggio, trasporti, istruzione, assistenza sanitaria e altri beni e servizi comuni. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti raccoglie ogni mese i prezzi in 75 aree urbane e li confronta con quelli del periodo precedente.
Perché è importante?
Il CPI è utilizzato per misurare l’inflazione, cioè quanto aumenta il costo della vita. Se il CPI sale, significa che i prezzi stanno aumentando e che, in media, si deve spendere di più per vivere come si faceva prima.
Bitcoin e CPI: come sono legati?
Il Consumer Price Index è uno dei principali indicatori che i membri della Federal Reserve prendono in considerazione quando devono effettuare delle scelte in materia di politica monetaria: generalmente, quando l’inflazione scende, il FOMC (Federal Open Market Committee) è più sereno nel tagliare i tassi e viceversa.
Attualmente, tuttavia, gli analisti credono che il Presidente della Fed e il gruppo di Governatori – Board of Governors – che presiede il FOMC, siano inclini a mantenere stabili i tassi anche per le prossime riunioni, al fine di valutare l’impatto dei tagli effettuati durante il 2025.
In ogni caso, il CPI resta uno strumento fondamentale per comprendere l’andamento dell’inflazione e cercare di prevedere il comportamento della banca centrale americana: se ti interessa il tema, trovi tutte le date per il 2026 nel nostro articolo sul calendario delle riunioni della Fed.
L’ultima volta che è successo
L’ultimo CPI di gennaio è risultato inferiore rispetto alle previsioni e al CPI del mese precedente: il dato, coerentemente con quanto scritto sopra, non ha influenzato le scelte della Fed la quale, come abbiamo anticipato, ha lasciato i tassi ai livelli di dicembre
Quindi, com’è andato il CPI di oggi?
Entra nel nostro canale Telegram
CPI di febbraio 2026: l’analisi dei dati
Il 13 febbraio 2026, il BLS ha pubblicato il report relativo ai cambiamenti dei prezzi per i consumatori statunitensi. Secondo il rapporto, il CPI mensile (MoM) è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente, così come il CPI anno su anno (YoY), in crescita del 2,4%. Questo dato è abbastanza positivo, poiché l’inflazione anno su anno è stabile e resta vicina al target imposto dalla FED, cioè il 2%.
Cosa significano questi numeri?
Il fatto che il CPI sia salito dello 0,2% mese su mese e del 2,4% anno su anno, significa che l’inflazione sembra essere entrata in una fase di stabilizzazione: le rilevazioni sono di poco inferiori rispetto a quelle del mese precedente. A gennaio, infatti, il report del BLS segnava un aumento dello 0,3% MoM e del 2,6% YoY.
Cosa deciderà la Fed riguardo ai tassi di interesse nel FOMC del 17-18 marzo 2026? Sul FedWatch Tool, lo strumento principe per questo tipo di previsioni, le probabilità del taglio di 25 punti base ancora molto basse, al 9,8%.
Il CPI anno su anno nel 2026
Febbraio 2026: 2,4% (previsto 2,5%)
Gennaio 2026: 2,6% (previsto 2,7%)
Dati del 2025:
Dicembre 2025: 2,7% (previsto 3,1%)
Ottobre 2025: 3% (previsto 3,1%)
Settembre 2025: 2,9% (previsto 2,9%)
Agosto 2025: 2,7% (previsto 2,7%)
Luglio 2025: 2,7% (previsto 2,7%)
Giugno 2025: 2,4% (previsto 2,5%)
Maggio 2025: 2,3% (previsto 2,4%)
Aprile 2025: 2,4% (previsto 2,5%)
Marzo 2025: 2,8% (previsto 2,9%)
Febbraio 2025: 3% (previsto 2,9%)
Gennaio 2025: 2,9% (previsto 2,9%)
Per continuare a seguire questi aggiornamenti sul mercato, iscriviti al nostro canale Telegram o clicca qui sotto!