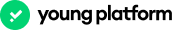Il portafoglio attuale deve tenere in considerazione che il mondo è cambiato e con esso anche le strategie di investimento. Come muoversi?
Investire oggi significa concepire e costruire il portafoglio di investimento come uno strumento in grado di assorbire gli shock esterni senza capitolare: in due parole, dovrebbe essere diversificato. Fino a qualche anno fa, vi erano alcune linee guida precise e condivise prese come riferimento nel processo di pianificazione finanziaria. Oggi la situazione è cambiata. Che fare?
Perché bisognerebbe ripensare le strategie di investimento?
Il mondo, negli ultimi 5 anni, è completamente cambiato. Dal 2020 – almeno – stiamo assistendo a una serie di eventi che stanno stravolgendo l’ordine costituito a cui eravamo abituati.
Tutto ciò che davamo per scontato e immutabile a proposito di interventi militari, alleanze geopolitiche e accordi economici, sta evolvendo verso un nuovo assetto. Per dirla in breve, potremmo essere arrivati al capolinea della fase di globalizzazione assoluta, cominciata con la dissoluzione dell’Unione Sovietica del 1991.
Le basi: da dove parte tutto ciò?
Il momento di avvio di questo processo di netto cambiamento potremmo collocarlo nel periodo tra gli anni 2018 e 2022. Nel quinquennio, tre accadimenti storici hanno contribuito a modificare gli equilibri passati: la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, la pandemia da Covid-19 e l’invasione russa dell’Ucraina.
La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina
Nel marzo del 2018, infatti, l’amministrazione americana guidata proprio da Donald Trump impose dazi al 25% su circa 50 miliardi di merci importate dalla Cina, a seguito di un report di Robert Lighthizer, Rappresentante per il Commercio USA, in cui si denunciavano alcune pratiche commerciali scorrette da parte della Repubblica Popolare. Questa, naturalmente, rispose e impose tariffe su 128 prodotti strategici americani.
Si diede inizio a una guerra commerciale che svelò le criticità di un sistema super connesso, forse troppo dipendente dalla manifattura cinese: il deterioramento dei rapporti coincise con la crisi delle catene di approvvigionamento. Inoltre, i toni di scontro fra le due principali potenze mondiali, che incarnavano – e incarnano tuttora – allo stesso tempo due sistemi economici e politici contrapposti, contribuirono alla riemersione di dinamiche di polarizzazione proprie di tempi passati, soprattutto del periodo della Guerra Fredda. Le cancellerie del mondo tornarono a porsi una vecchia domanda: da quale parte schierarsi? Stati Uniti o Cina?
La pandemia da Covid-19
Arriviamo al 2020: a febbraio è epidemia, a giugno è pandemia. Il Covid-19 blocca il mondo e Papa Francesco può camminare da solo in Via del Corso a Roma. Iconografie a parte, il lockdown prolungato amplificò i problemi legati alla supply chain, emersi nel biennio precedente, oltre a immobilizzare la produzione nazionale: come riporta Statista, il Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale subì una contrazione del 3,4% o, in dollari, di 2 trillion. Ovviamente, anche i mercati finanziari incassarono il colpo: il Dow Jones (DJI) – l’indice più importante al mondo – perse il 35% circa da metà febbraio a metà marzo. Nello stesso periodo, Bitcoin passò da 9.970$ a 5.300$, una diminuzione del 46,6%.
Come sappiamo, sia il PIL che i mercati recuperarono dalla botta con un rimbalzo clamoroso: da quel momento ad oggi, il DJI ha guadagnato il 144%, l’S&P500 il 187% e Bitcoin il 2.100% (percentuale che sale a 3.130% se consideriamo l’ATH a 126.000$).
Iniziarono a circolare le info sui primi vaccini, il panico collettivo si ridusse e la fiducia tornò a livelli accettabili. Ma soprattutto, i governi di tutto il mondo inondarono le rispettive economie con una quantità infinita di liquidità e stimoli fiscali.
Prendendo in considerazione solo le tre principali potenze economiche, gli Stati Uniti ratificarono il CARES Act da 2,2 trillion di dollari, la Cina approvò un piano da 3,6 trillion di yuan (circa 500 miliardi di dollari) e l’Unione Europea mise in campo una serie di interventi – i più importanti il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) e il NextGenerationEU – per un totale di quasi 2 trillion di dollari. A questo, occorre aggiungere le varie misure di politica economica finalizzate a ridurre il costo del denaro: tassi di interesse bassi, quantitative easing e così via.
Oggi, solo negli USA, la M2 Money Stock, cioè la quantità totale di dollari in circolazione nell’economia reale, ha raggiunto i 22 trillion dai 15,4 trillion di febbraio 2020. A questo punto, un grande problema si iniziava ad aggirarsi fra i corridoi delle banche centrali di tutto il mondo. Un problema su cui noi, in Young Platform, dedichiamo moltissimo tempo: l’inflazione. Ma il “bello doveva ancora arrivare”.
La Guerra russo-ucraina
Febbraio 2022: la Russia di Putin invade l’Ucraina, è la tempesta perfetta. Sorvolando la questione umanitaria che, pur essendo centrale e gravissima, non è il target del nostro articolo, la Guerra russo-ucraina è considerata il catalizzatore decisivo: il suo scoppio coincide con la conclusione di quel periodo di pace apparente e libera circolazione delle merci reso possibile dalla globalizzazione di stampo americano.
Russia e Ucraina, prima della guerra, erano nodi vitali per il commercio globale. Basti pensare che, insieme, i due Paesi rappresentavano il 30% circa dell’export mondiale di grano e cereali a basso costo, mentre la Russia era uno dei principali fornitori europei di gas, oltre a ricoprire una posizione di prim’ordine nella fornitura di fertilizzanti in giro per il mondo – necessari all’agricoltura.
Con la guerra, tutto ciò cessa di esistere. La conversione delle economie russa e ucraina a economie di guerra provoca grandi difficoltà strutturali all’interno dei due Paesi, che non producono più ai livelli pre-conflitto e non riescono a soddisfare la domanda. Inoltre, le filiere ora sono politicizzate: se prima si comprava dove era conveniente, adesso si cerca di acquistare dagli alleati, anche a prezzi più alti (sanzionando i nemici). Infine, il danneggiamento e i blocchi strategici delle infrastrutture logistiche – come i porti ucraini del Mar Nero – costituiscono un impedimento permanente all’accesso delle risorse.
Lo stato attuale delle cose
Sono definitivamente crollati alcuni tra i pilastri che resero possibile la creazione di un’economia globale interconnessa ed efficiente, come la disponibilità costante di materie prime a basso costo, il trasporto internazionale a costi irrisori e la sicurezza logistica, ovvero la certezza di ricevere merci senza interruzioni o ritardi. In poche parole: è la fine del modello JIT (Just-In-Time).
È cambiato il paradigma. La priorità è la sicurezza degli approvvigionamenti, non l’efficienza, anche in virtù della politicizzazione delle supply chain menzionata poco fa. L’esempio più recente è la decisione della Cina di limitare l’accesso alle terre rare su base discrezionale, a cui Trump ha risposto imponendo tariffe al 100%: l’emergenza è “rientrata” in pochi giorni, ma queste tensioni hanno causato liquidazioni per miliardi di dollari.
L’inflazione diventa un problema persistente in quanto sistemico, anche perché è importata, cioè a monte: se prima il fornaio vendeva il pane a 5 perchè pagava le bollette 2 e la farina 1, tenendo per sé un altro 1, adesso paga le bollette 3 perchè non può più avvalersi del gas russo a basso costo, la farina 2 ed è costretto ad alzare il prezzo finale per guadagnare 1 – abbiamo approfondito l’argomento dopo esserci chiesti per quale motivo il prezzo del pane aumentasse di anno in anno.
In Italia, per esempio, dal 2004 al 2021 i prezzi sono cresciuti a ritmo lento e costante: come riporta Pagella Politica, in 17 anni l’incremento è stato pari al 28%, con una media annua dell’1,5%. Solamente nel 2022, invece, l’indice generale dei prezzi è salito dell’11%, per scendere all’8% nel 2023 e tornare al 2% nel 2024. Detto in un altro modo, per utilizzare le parole degli autori della ricerca, “poco meno della metà dell’incremento accumulato in vent’anni si è quindi concentrato in soli tre anni”.
Ora che abbiamo un quadro chiaro delle trasformazioni in atto e delle loro cause, è arrivato il momento di rispondere alla domanda centrale.
Investire oggi: cosa è necessario considerare?
Nel mondo attuale, la variabile principale da considerare quando si vuole costruire un portafoglio – come abbiamo visto – è l’alta inflazione, ormai elemento costitutivo del nostro sistema economico.
In passato, nel mondo degli investimenti, una “regola” in particolare ha influenzato l’arte della diversificazione per moltissimo tempo: il celebre portafoglio 60/40. In due parole, questa stabiliva che il portafoglio perfetto dovesse essere composto per il 60% dall’azionario e per il 40% dall’obbligazionario.
Il motivo è semplice: la correlazione negativa tra le due asset class. Questo perché, nel “vecchio mondo”, nei periodi di crescita economica le azioni performavano meglio delle obbligazioni e, al contrario, nei momenti di recessione le obbligazioni – o bond – compensavano le perdite delle azioni. In questo momento storico, tuttavia, il portafoglio 60/40 potrebbe non essere più così valido.
Azioni e obbligazioni sono sempre più correlate e le seconde sarebbero gradualmente perdendo lo status di safe haven – rifugio sicuro per preservare il capitale – in favore di altri asset.
L’inflazione, infatti, costituisce un grosso problema per le obbligazioni, per almeno due motivi: in primo luogo gli investitori che le detengono ricevono in cambio degli interessi fissi, o cedole, che si stanno rivelando inadatti a proteggere il capitale dalla perdita di potere d’acquisto; in secondo luogo, con un’inflazione così radicata, le banche centrali sono costrette a tenere i tassi alti provocando, in ultima istanza, una discesa del valore delle obbligazioni.
Per fare esempio, prendiamo il TLT, un ETF che permette agli investitori di esporsi sui titoli di stato USA con scadenze superiori ai 20 anni: dal suo lancio nel 2002, fino al 2020, il TLT ha performato abbastanza bene, crescendo in modo lento ma costante, mettendo a segno il +100% circa, con l’ATH proprio nella prima settimana di marzo 2020. Da quel momento, tuttavia, è iniziato un declino clamoroso: da aprile 2020 ad oggi, questo ETF ha perso più del 40%. Se avessi investito nel TLT al day zero nel 2002, oggi avresti guadagnato il 10% scarso.
Dove investire i soldi oggi?
Naturalmente, prima di cominciare questa sezione, è necessario ricordare che ciò che leggerete qui non sono consigli di investimento, o consigli finanziari (come dice la formula), ma solo considerazioni che prendono piede dalla lettura di pareri di esperti – il disclaimer, quello preciso e accurato, è in fondo all’articolo.
Detto ciò, un’analisi interessante proviene dalle mura di Goldman Sachs, più precisamente dalla sezione dedicata alle analisi di mercato, la Goldman Sachs Research. Nello studio, coerentemente con quanto scritto finora, si legge che una strategia di “accettazione passiva”, come l’investimento in indici globali (World Portfolio), potrebbe non essere più così funzionale. Al contrario, potrebbe essere più adatto il cosiddetto Strategic Tilting, letteralmente “Inclinazione Strategica”, ovvero la gestione quasi attiva del proprio portafoglio per salvaguardarsi dalle vulnerabilità attuali – inflazione in primis.
Fare Strategic Tilting, dunque, significa diversificare ma in modo consapevole. Una metafora semplice, che ci aiuta a comprendere il concetto, arriva dall’ambito culinario.
Immagina di voler preparare la tua torta preferita, quella che ti ha insegnato nonna da piccolo quando tornavi da scuola. Bene, la ricetta di nonna, con le quantità e i tempi di cottura, funzionava perfettamente col forno di casa di nonna. Il tuo forno, invece, scalda di più.
È una variabile che devi considerare, altrimenti la torta verrà totalmente differente e, magari, bruciata. Pertanto soppesi gli ingredienti in modo tale che il problema del tuo forno venga minimizzato: dei 500 grammi di farina, ne togli 50 per sostituirli con altri 50 grammi di amido per ammorbidire.
Ora, la ricetta classica di tua nonna è l’indice globale, che funzionava perfettamente col vecchio forno (il “vecchio mondo”). Il forno nuovo, tuttavia, è più potente – il contesto macroeconomico è diverso, l’inflazione è strutturale. Per questo motivo, hai cambiato gli ingredienti o, in termini finanziari, hai gestito attivamente – ma non troppo – le tue allocazioni, affinchè la torta (l’investimento) possa performare al meglio. Questo è lo Strategic Tilting.
L’analisi, in merito, descrive cinque macroaree da considerare per mitigare i rischi.
- Protezione dall’inflazione: il portafoglio 60/40, lo abbiamo visto, fatica a proteggere il capitale dall’erosione inesorabile dell’inflazione. Per questo motivo, spiegano gli esperti della sezione Research, è necessario ribilanciarlo incrementando l’esposizione agli asset reali – immobiliare, materie prime e risorse naturali – e all’oro. In merito, il Chief Information Officer di Morgan Stanley Mike Wilson ritiene che il nobile metallo debba pesare almeno il 20%. Con la speranza che non si verifichino altri crash come quello di ottobre.
- Protezione dalla fine del dominio degli Stati Uniti: nuove potenze sfidano quotidianamente la leadership degli USA nel mondo, Cina in testa. Per questa ragione, le azioni non-statunitensi meriterebbero maggiore attenzione al momento in cui si pianifica una strategia a medio-lungo termine.
- Protezione dal dollaro debole (Pt.1): la causa e allo stesso tempo la conseguenza del secondo punto. Se gli Stati Uniti perdessero la leadership, il dollaro smetterebbe di essere il centro della finanza mondiale. Il discorso vale anche al contrario: se la dedollarizzazione prendesse forza, gli USA cederebbero il comando. In funzione di ciò, i mercati emergenti, storicamente correlati negativamente col dollaro, potrebbero rappresentare un’ancora di salvezza.
- Protezione dal dollaro debole (Pt.2): per tutelarsi da questo fenomeno, ha senso anche ridurre l’esposizione in USD e iniziare a guardare verso altri lidi, come euro franco svizzero.
- Protezione dalla volatilità: le azioni Tech statunitensi, che hanno un peso immenso nell’S&P500 e nel Nasdaq, sono molto volatili. Per esempio, le trimestrali di NVIDIA hanno spostato il titolo dell’8% in un giorno – da +5% a -3% in una seduta. In questo senso, le azioni low volatility possono attenuare gli scossoni: utilities (aziende che forniscono servizi di pubblica utilità) e healtcare (salute pubblica).
Le strategie sono cambiate?
Per rispondere alla domanda di apertura: si, le strategie sono cambiate. I nuovi paradigmi di investimento, per essere al passo coi tempi, dovrebbero inserire nell’equazione alcuni parametri che ormai non possono essere più ignorati. Le scuole di pensiero sono molte e propongono approcci diversi fra loro. Il denominatore comune, però, è uno: il portafoglio 60/40, massima espressione di un mondo ormai passato, potrebbe non essere più la cura per tutti i mali.
Iscriviti al nostro canale Telegram e a Young Platform per restare aggiornata/o sulle notizie davvero importanti che, ogni giorno, muovono i mercati.
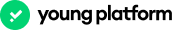
Registrati su Young Platform!