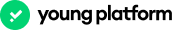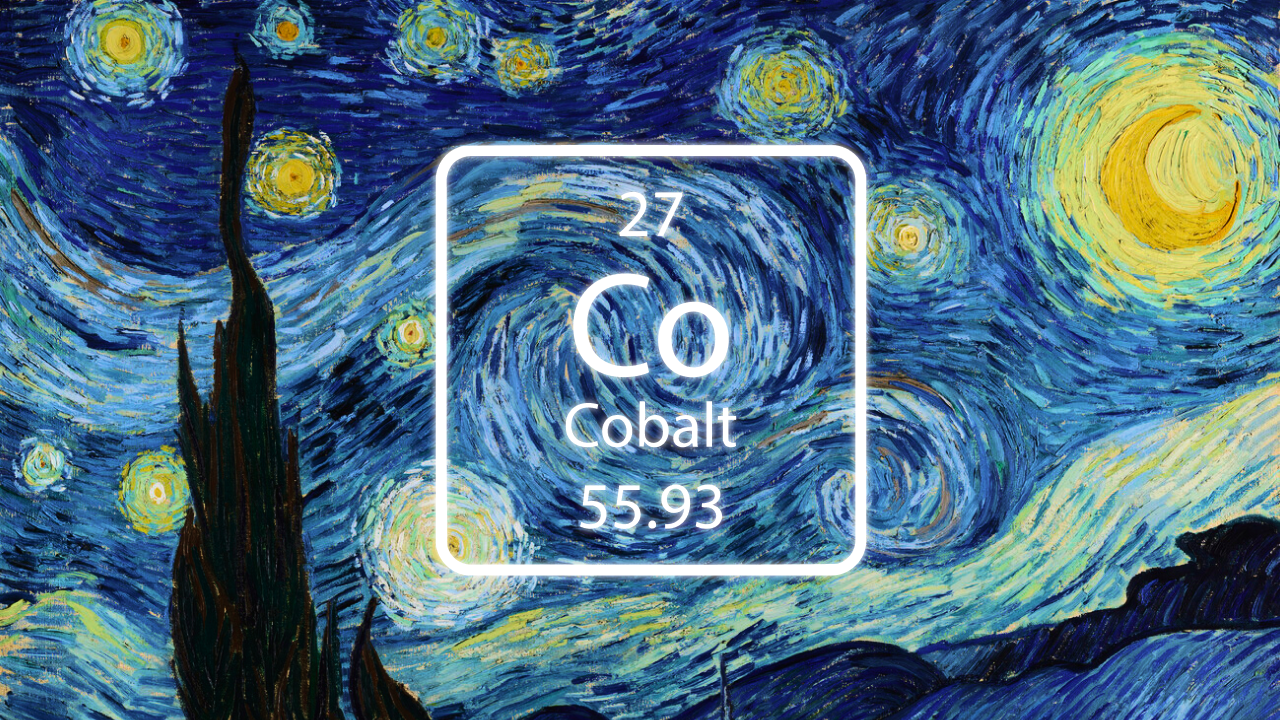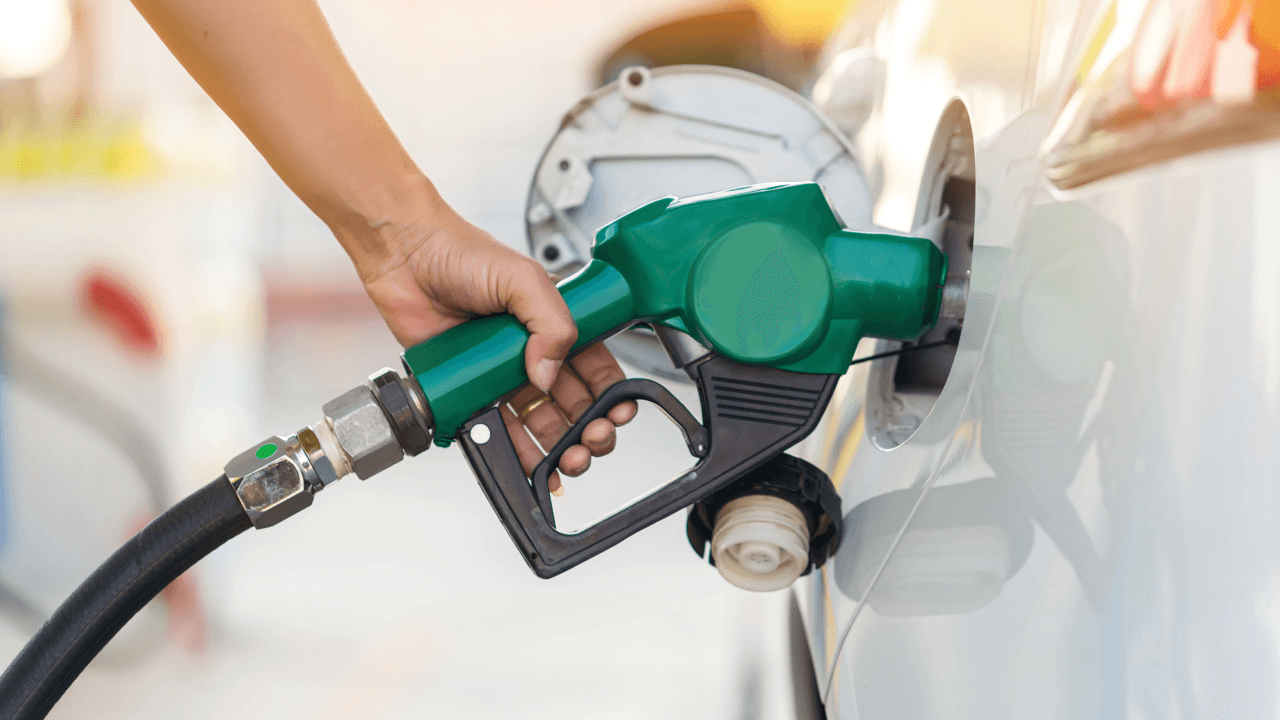Cosa sono i Labubu? I peluche virali amati dalle star. È corretto parlare di Lipstick Effect?
Avete presente quei trend che esplodono dal nulla sui social? Ecco, i Labubu sono l’ultimo grido in fatto di “ma cosa sta succedendo?”. Questi animaletti pelosi sono comparsi all’improvviso e hanno preso la residenza permanente sulle borse delle dive più famose del pianeta, diventando i protagonisti indiscussi di TikTok e delle sfilate più cool delle Fashion Week.
Ma cosa sono esattamente questi Labubu? Come hanno fatto a raggiungere l’incredibile popolarità di cui godono oggi, trasformandosi da semplici portachiavi a status symbol ambitissimi? E, soprattutto, cosa c’entra tutto questo con la teoria economica del “lipstick effect?“
La storia dei Labubu
Per capire fino in fondo chi o cosa siano i Labubu, questi pupazzetti di peluche nati originariamente come simpatici portachiavi da attaccare a zaini, borse o ovunque ci sia spazio per un tocco di stravaganza, possiamo partire da un episodio emblematico avvenuto qui da noi, in Italia. Immaginate la scena: Milano, Corso Buenos Aires, uno dei templi dello shopping. Davanti al negozio di Pop Mart – un colosso cinese nel mondo dei giocattoli da collezione – si forma, fin dalle prime luci dell’alba, una coda chilometrica, degna del lancio di un iPhone o del concerto di una rockstar. Il motivo? L’arrivo dell’ultima, attesissima collezione di Labubu. Un evento che ha scatenato la curiosità anche in chi, fino a quel momento, di questi mostriciattoli pelosi non aveva mai sentito parlare.
Ma chi ha dato vita a questi oggetti del desiderio ormai virali? Il padre dei Labubu è Kasing Lung, un artista originario di Hong Kong. Questi pupazzi non sono creature solitarie, ma fanno parte di un universo ben più ampio, popolato da una miriade di mostriciattoli noti collettivamente come “The Monsters”. Dal punto di vista artistico, ciò che rende i Labubu particolarmente interessanti è la loro capacità di fondere due stili apparentemente agli antipodi: da un lato, le influenze orientali, proprie delle radici dell’artista; dall’altro, l’immaginario delle fiabe nordiche europee, un mondo che Kasing Lung ha conosciuto da vicino avendo trascorso parte della sua infanzia in Belgio. In realtà i Labubu non sono una novità dell’ultima ora: i primi modelli, infatti, risalgono addirittura al 2015, anche se è solo nel 2019 che Pop Mart ne ha fiutato il potenziale, acquistandone i diritti e preparandoli per il grande salto verso la fama globale.
Ma perché tutti impazziscono per un Labubu?
Se la miccia della popolarità dei Labubu era stata accesa da tempo, l’esplosione vera e propria, quello tsunami di cui parlavamo prima, ha un epicentro ben preciso: il profilo social di Lisa Manoban, la carismatica rapper e cantante delle Blackpink, il gruppo femminile K-Pop più famoso e influente del pianeta (nonché una delle attrici protagoniste dell’ultima, acclamata stagione di The White Lotus). È stata lei a dare il la definitivo. Verso la fine del 2024, Lisa ha iniziato a condividere con i suoi milioni di follower la sua passione per questi animaletti, sfoggiandoli regolarmente come accessori fashion agli eventi più glamour, attaccati alle sue borse firmate. Potete immaginare l’effetto: un’onda mediatica inarrestabile, di quelle che solo i social network, con la loro potenza virale, sanno generare e amplificare.
Da quel momento in poi, è stato il delirio collettivo. Altre dive di calibro internazionale come Dua Lipa, Kim Kardashian, Selena Gomez e Rihanna hanno iniziato a “indossare” questi curiosi accessori, facendoli penzolare dalle loro it-bag. Risultato? Una caccia al Labubu senza precedenti, con un’inevitabile e vertiginosa esplosione del prezzo degli esemplari più rari e delle edizioni limitate che gli ha trasformati in veri e propri oggetti da collezione e investimento.
Il fenomeno Labubu significa recessione?
Ora passiamo alla parte meno glamour, ma decisamente più intrigante del fenomeno: la sua possibile connessione con il periodo di incertezza economica, se non di vera e propria recessione, che stiamo attraversando. Questo legame, all’apparenza bizzarro, trova una spiegazione piuttosto affascinante in un concetto economico noto come “lipstick effect“, o “effetto rossetto”. Niente paura, non serve una laurea in economia per capirlo! In breve, questa teoria descrive la tendenza, osservata più volte nella storia, dei consumatori a preferire l’acquisto di beni di lusso più economici e accessibili durante i periodi di crisi economica. Quando il portafoglio piange e i grandi acquisti (come una macchina nuova o una casa) diventano un miraggio, ci si consola con piccole gratificazioni, piccoli lussi che ci fanno sentire meglio senza svuotare il conto in banca.
Ma da dove salta fuori questa idea del rossetto come indicatore economico? Per capirlo, dobbiamo fare un salto indietro. Il termine “lipstick effect” è stato reso popolare da Leonard Lauder (non Alan, ma il figlio di Estée Lauder e presidente emerito di Estée Lauder Companies) durante la recessione che colpì gli Stati Uniti dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e l’inizio della guerra in Afghanistan. Lauder notò un fatto curioso: mentre molti settori dell’economia barcollavano e la domanda per beni costosi crollava, le vendite dei suoi prodotti cosmetici, e in particolare dei rossetti, non solo tenevano botta, ma addirittura aumentavano. Strano, no? Dopotutto, un rossetto non è certo un bene di prima necessità.
In realtà, l’intuizione che i piccoli lussi potessero avere un ruolo speciale in tempi duri non era del tutto nuova. Si dice che persino Winston Churchill, durante la Seconda Guerra Mondiale, dovendo razionare una vasta gamma di prodotti, escluse categoricamente i cosmetici dalla lista. La sua motivazione? Erano considerati necessari per tenere alto il morale della popolazione, soprattutto femminile, in un periodo di enormi sacrifici e preoccupazioni. Un piccolo gesto di normalità e cura di sé in un mondo sottosopra.
Ma perché proprio i rossetti (e per estensione, altri piccoli piaceri come i Labubu oggi) diventano beni “a prova di crisi”? La chiave sta nella gratificazione psicologica che deriva dall’acquisto di qualcosa che soddisfa un piccolo desiderio, una piccola vanità, specialmente quando si è costretti a rinunciare a molto altro. In periodi di crisi, con il morale spesso a terra e le preoccupazioni per il futuro dei propri risparmi, l’acquisto di un prodotto che rimanda alla sfera estetica, al piacere personale, può contribuire a migliorare significativamente l’umore. Un rossetto di marca, un profumo, un accessorio carino e alla moda come un Labubu, per quanto non strettamente necessari, diventano una sorta di coccola accessibile, una strategia per sentirsi meglio.
A volte, si rinuncia al solito prodotto economico per concedersi una versione un po’ più costosa e desiderabile di quel piccolo lusso. È il cosiddetto consumo compensativo: non posso permettermi la borsa da sogno da migliaia di euro, ma posso attaccarci un Labubu da collezione che mi dà una simile (anche se minore) scarica di dopamina. Le relazioni sociali giocano anche un ruolo: mantenere un certo standard estetico o possedere l’oggetto del momento può aiutare a preservare l’autostima e il senso di appartenenza. Queste dinamiche psicologiche, molto potenti poiché poco razionali, vengono sfruttate da criminali che, online, hanno iniziato a vedere falsi a prezzi altissimi. Di che si tratta?
Labubu e scam: attenzione alle frodi sempre più numerose!
I Labubu, dato il loro incredibile quanto repentino successo, sono diventati uno degli oggetti preferiti degli scammer online per truffare clienti ignari, convinti di comprare un esemplare originale. Ce lo riferisce Kaspersky, un’azienda di sicurezza informatica e privacy digitale fondata nel 1997, operativa in tutto il mondo. Il modus operandi di questi truffatori, scrive Kaspersky, è sempre lo stesso, vecchio come la storia dell’uomo. Vediamo insieme cosa ha partorito il grande genio di questi venditori di illusioni digitali.
Come abbiamo anticipato, il gioco si basa sulle dinamiche di gratificazione psicologica e pressione sociale di cui parlavamo nel capitolo precedente. Il punto è che, per molte persone, avere quel modello di iPhone in mano, indossare quel paio di scarpe ai piedi e, come nel nostro caso, appendere un pupazzetto alla borsa o allo zaino diventa questione di vita o di morte. Se a ciò aggiungiamo la dimensione competitiva, basata sul concetto di blind box – non puoi vedere quale Labubu ti è capitato prima di aprire la confezione – e sulla rarità di alcuni esemplari, il gioco è fatto.
Fondamentalmente, lo scam si costruisce intorno a pochissimi elementi: la creazione di un sito falso ma estremamente simile nell’estetica a quello ufficiale di Pop Mart, Labubu “rari” ma fake in vendita – spesso a prezzi scontati – e furto di dati personali finanziari, che poi utilizzeranno per drenare il conto corrente della vittima.
Immagina la scena: un appassionato di Labubu che finisce inconsapevolmente su uno di questi siti-truffa. Dà un’occhiata al catalogo, non crede ai suoi occhi. Finalmente ha trovato il Sacro Graal dei Labubu, pure a prezzo scontato! “Non c’è tempo da perdere”, pensa, “devo assolutamente comprarlo prima qualcun altro lo trovi!” e procede a inserire tutti i dati possibili e immaginabili, perché la smania di entrare in possesso di quel simpatico mostriciattolo lo acceca e gli impedisce di ragionare. Pagamento fatto, arriva la mail: “Grazie per l’acquisto! Il tuo Labubu verrà spedito a breve!”. Il nostro appassionato si rilassa e finalmente riprende a respirare. Ma i giorni passano e di Labubu non c’è traccia. Un dubbio lo assale, “fammi andare a controllare”, dice. Si precipita sul sito e legge ciò che sperava di non leggere mai: anzichè Pop Mart, c’è scritto Pop Mert. Apre la sua app di home banking: conto svuotato. Fine della storia.
I Labubu, tutto sommato, ci hanno insegnato qualcosa
In primo luogo, sul ruolo del lipstick effect nell’economia, che è oggettivamente interessante e dice molto sul comportamento umano in alcuni tipi di situazione. Questo effetto, poi, sembra manifestarsi ancora oggi. Dati di mercato degli anni scorsi (ad esempio, quelli analizzati da società come Circana per il 2022-2023) hanno mostrato come le vendite di prodotti di bellezza abbiano continuato a crescere, con un aumento significativo anche per i cosmetici di lusso, nonostante un contesto economico globale non proprio roseo.
In secondo luogo, sulla fragilità dell’essere umano che, a prescindere dall’epoca in cui si trova, dalla città in cui vive o dalla cultura a cui appartiene, verrà sempre schiacciato dalle pulsioni emotive che, in determinate condizioni, annebbiano il pensiero razionale: se il nostro amico avesse perso due minuti in più prima di acquistare, avrebbe notato quella E al posto della A e avrebbe evitato di buttare i soldi.
In ogni caso, ora dovrebbe essere un po’ più chiaro cosa sono questi adorabili (e costosi, per i collezionisti!) pupazzetti Labubu e perché sono diventati virali nel giro di pochissimo tempo. Occorre chiederci, piuttosto, quanto durerà questa moda. Nel dubbio, iscriviti al nostro canale Telegram che ti aggiorniamo noi!