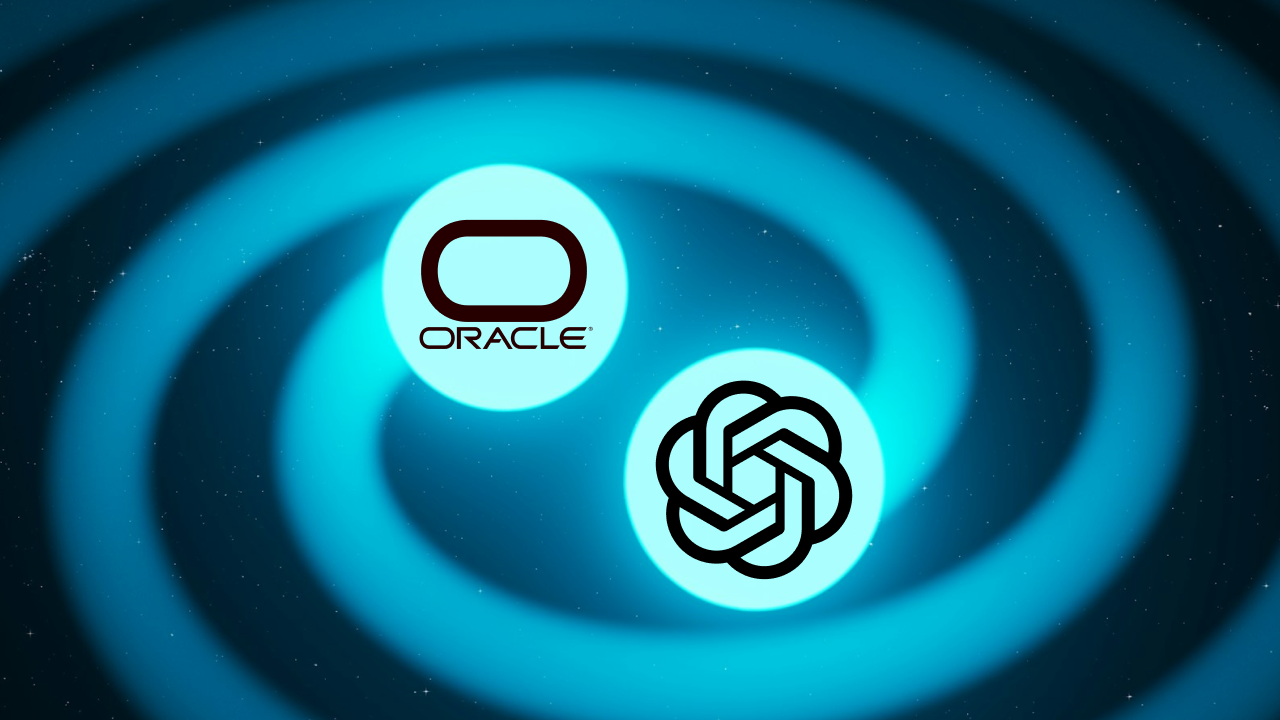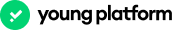Ethereum è vicino al decimo compleanno! Ci pensi? Dieci anni dal lancio ufficiale della blockchain e del token ETH. Vediamo insieme i momenti chiave!
Il prossimo 30 luglio ricorreranno dieci anni esatti dal lancio ufficiale della blockchain di Ethereum e del suo token nativo ETH. Dieci anni di innovazione e sviluppo che hanno reso l’ecosistema un gigante da più di mille miliardi di dollari. La strada, però, è ancora lunga. In questo articolo, che vuole essere un tributo alla sua storia, ripercorreremo le 10 tappe più significative del percorso di Ethereum e della figura che più lo rappresenta, Vitalik Buterin.
Vitalik Buterin ed Ethereum: un destino già segnato?
La passione per la crittografia non è così comune come quella per il calcio o per la musica rock. A maggior ragione nel 2013, quando l’argomento non era così popolare e gli strumenti non così diffusi.
L’ambiente, però, può condizionare notevolmente la personalità, le passioni e le esperienze di un individuo, specialmente se poi quest’ultimo è la persona giusta al momento giusto. Questo è il caso di Vitalik Buterin, un ragazzo nato a Kolomna, in Russia, nel 1994 ed emigrato in Canada con la sua famiglia solo qualche anno dopo.
Perché Vitalik potrebbe rientrare in questa statistica? Perché il padre, Dmitry Buterin, è un ingegnere informatico che ha fondato (e venduto) tre aziende multimilionarie e che – legittimamente – si definisce un “serial tech entrepreneur”. La passione di Dmitry per la tecnologia e la Computer Science lo ha portato, nel 2011, a scoprire Bitcoin e a condividere questa “scoperta” col figlio Vitalik, ai tempi 16enne.
Bene, come anticipato, Vitalik era la persona giusta al momento giusto: in terza elementare viene inserito in una classe speciale di bambini plusdotati (in inglese gifted) dove sviluppa la sua passione per la matematica e la programmazione. In quinta elementare ha già il titolo di “math genius”. A 16 anni è in grado di comprendere perfettamente la natura e il potenziale di Bitcoin tanto da fondare, a 17 anni, una rivista dedicata: Bitcoin Magazine, attiva ancora oggi.
A 19 anni, nel 2014, Vitalik Buterin pubblica il whitepaper di Ethereum
“Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform”. Così inizia il whitepaper che Vitalik, nel 2014, rende pubblico alla Bitcoin Conference di Miami.
Ma da cosa nasce la necessità di creare Ethereum?
Da un assunto che, col senno di poi, può sembrare molto semplice. Vitalik da una parte riconosce il valore di Bitcoin come valuta digitale peer-to-peer e come blockchain basata sul meccanismo di consenso Proof-of-Work. Dall’altra, però, è consapevole dei suoi limiti e del bisogno di ampliarne le funzioni.
“Ciò che Ethereum intende offrire”, si legge nel whitepaper, “è una blockchain dotata di un linguaggio di programmazione integrato e Turing-completo, che può essere utilizzato per creare “contratti” in grado di codificare funzioni di transizione di stato arbitrarie. Questo consente agli utenti di realizzare qualsiasi sistema […] semplicemente scrivendone la logica in poche righe di codice”. In pochissime e semplici parole, l’idea era quella di sviluppare un mega computer globale e decentralizzato.
L’interesse fra gli addetti ai lavori, che hai tempi erano ancora considerati come parte di una nicchia, è incredibile: la Thiel Fellowship, associazione creata da uno dei king della Silicon Valley nonché fondatore di PayPal e Palantir Peter Thiel, gli offre una borsa di studio da 100.000$ per portare avanti il progetto. È l’inizio di una storia epica.
Profit or no-profit, questo è (primo) il dilemma
Siamo sempre nel 2014, le cose si fanno via via più serie. Vitalik e gli altri sette co-founder si riuniscono a Zug, in Svizzera, il 7 giugno per compiere un’importante passo: trasformare Ethereum in un’azienda for-profit e iniziare a guadagnarci sopra.
Come riferirà in un’intervista Joe Lubin, uno dei co-founder, “Io, con diverse persone del team, credevo che fosse necessario attirare le aziende, che servisse un riscontro economico e commerciale per riuscire a costruire cose migliori”.
Ma Vitalik, il primus inter pares fra i co-founder, la mente dietro tutto quanto, non è d’accordo. Così esce in balcone, si ferma a riflettere e poi rientra. La decisione è presa: Ethereum deve essere una fondazione no-profit. Subito dopo, caccia Amir Chetrit e Charles Hoskinson – che poi fonderà Cardano – dal progetto. Nasce la Ethereum Foundation.
La ICO e il lancio ufficiale
Verdetto emesso, riunione chiusa, è ora di iniziare a costruire qualcosa di significativo. Il primo step è ovviamente raccogliere quanto più capitale possibile. Il 22 luglio 2024 comincia la ICO di Ethereum che termina il 2 settembre dello stesso anno: in 42 giorni, la Ethereum Foundation riesce ad attrarre finanziamenti per circa 18 milioni di dollari in BTC, scambiando agli investitori 2.000 Ether per 1 Bitcoin (1 ETH = 0,31$).
Il 30 luglio 2015, diciotto mesi dopo l’annuncio, la blockchain di Ethereum e il suo token nativo Ether vengono ufficialmente lanciati con la fase Frontier. In quel giorno, Ethereum, da che era un progetto su un documento di 36 pagine, diventa a tutti gli effetti una rete operativa e accessibile agli sviluppatori. Il grande pubblico avrebbe dovuto aspettare circa 9 mesi per la fase Homestead, che avrebbe introdotto un’interfaccia grafica più user-friendly.
L’hack di The DAO…
L’hack di The DAO è una storia talmente incredibile che meriterebbe un contenuto dedicato – magari in futuro. In ogni caso, siamo a maggio 2016, Ethereum non ha neanche un anno di vita ma nell’aria si sente già il profumo di innovazione e rivoluzione: Slock.it, un’azienda pioniera dell’esplorazione della blockchain, lancia The DAO su Ethereum con l’obiettivo di raccogliere fondi da investire in start up innovative.
Per dirla brevissima – se vuoi approfondire ti rimandiamo all’articolo sulle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) – The DAO è stata la prima organizzazione della storia totalmente decentralizzata, non gerarchica e disponibile su scala globale. Il funzionamento era abbastanza semplice: investendo ETH in Slock.it, si riceveva in cambio l’equivalente in TheDAO, il token che serviva per operare.
L’aspetto rivoluzionario risiede nel fatto che, possedendo TheDAO, per la prima volta i membri avevano diritto di voto sulla strada che The DAO avrebbe dovuto intraprendere: alla proposta “volete investire un numero X di ETH in questa start up con la promessa di ricevere X+10 ETH fra 6 mesi?”, gli holder di TheDAO potevano dire la loro. Adesso ci sembra scontato, soprattutto dall’esplosione della DeFi, ma nel 2016 è veramente un qualcosa nuovo, al punto che la ICO di TheDAO riesce a raccogliere in quattro settimane circa 150 milioni di dollari – 12 milioni di ETH. Ma era tutto troppo bello per essere… duraturo.
Arriviamo al 17 giugno 2016. Un giorno apparentemente normale, è passato un mese dal lancio di The DAO, ma improvvisamente qualcuno si accorge di qualcosa: gli Ether bloccati nello smart contract iniziano a sparire o, per meglio dire, ad essere trasferiti ad un ritmo di 100 ETH al secondo. C’è un attacco hacker in corso. Nel panico generale, però, un gruppo di eroi decide di prendere la situazione in mano: si tratta del Robin Hood Group (RGH) capitanato da Griff Green, community manager di Slock.it. Perché Robin Hood Group? Perché la loro strategia di contrattacco è tanto semplice quanto efficace: togliere gli ETH da The DAO prima che lo faccia l’hacker cattivo.
Inizia una furiosa battaglia fra il bene e il male fatta di tecnicismi e mosse che, come suggerito sopra, magari tratteremo un’altra volta. Ciò che conta, è che alla fine dello scontro il Robin Hood Group riesce a mettere in salvo il 70% degli ETH disponibili, mentre l’hacker se ne torna a casa con un 30%, equivalente a circa 2 milioni di Ether. Il prezzo del token, a causa di quanto accaduto, perde più della metà del valore, passando da 20$ a 9$.
…E il (secondo) dilemma: to Fork or not to Fork?
Alla fine della guerra fra “bene” e “male”, la community di Ethereum si trova di fronte a un secondo dilemma amletico: procedere col Fork o preservare l’immutabilità della chain?
Ma perchè questa domanda esistenziale? Per un cavillo interno alla DAO: gli ETH prelevati – nel caso dell’hacker, rubati – non erano immediatamente utilizzabili, ma dovevano rimanere bloccati per 28 giorni in un contract secondario.
Quindi, sulla base di ciò, l’hard fork – cioè la creazione di una nuova chain – avrebbe reso possibile “riscrivere le regole del gioco” e recuperare i fondi rubati. Come? Semplicemente inserendo una regola specifica: gli ETH bloccati sul contract secondario sarebbero stati reindirizzati a un wallet sicuro invece di essere trasferiti al wallet dell’hacker.
Qui il dilemma etico: da una parte, il Fork avrebbe consentito il recupero dei fondi rubati, dall’altra, avrebbe compromesso quello che forse è il principio cardine su cui si fonda la blockchain, cioè l’immutabilità della chain. I sostenitori del “Not to Fork” sottolineavano proprio questo aspetto: “se cambiamo le regole del gioco, quindi se violiamo il principio di immutabilità adesso, chi ci garantisce che non succederà in futuro?”
Alla fine, la community vota in maggioranza per il Fork: a partire dal blocco 1.920.000, la blockchain di Ethereum si sarebbe scissa in due: quella che oggi conosciamo col nome di Ethereum (ETH) ed Ethereum Classic (ETC).
I CryptoKitties mandano in delirio la community ed Ethereum si congestiona
Menzione d’obbligo per i CryptoKitties, la prima collezione NFT di sempre mai rilasciata sul mercato. Per dare un contesto, siamo nell’ottobre del 2017 e a Waterloo, in Canada, ha luogo l’ETHWaterloo, definito come il “World’s Largest Ethereum Hackathon”.
L’hackathon, qualora non lo sapessi, è un evento in cui vari sviluppatori si riuniscono per competere – ma anche collaborare – al fine di trovare soluzioni a problemi specifici o creare nuovi progetti. È una crasi fra le parole “hack” e “marathon”, proprio perché i partecipanti lavorano e programmano per un periodo di tempo compreso fra le 24 e le 48 ore. Al termine, si decretano i vincitori che, solitamente, ricevono premi in denaro.
Durante l’ETHWaterloo, il team dietro CryptoKitties, Axiom Zen, testa ufficialmente il programma di fronte a centinaia di sviluppatori e addetti ai lavori: si tratta di un gioco su blockchain in stile Tamagochi, in cui l’utente compra questi gatti-NFT e, fondamentalmente, li alleva, ci interagisce e li scambia. Ogni CryptoKittie possiede delle caratteristiche uniche che danno più o meno valore all’asset stesso: insomma, l’NFT per eccellenza da cui poi ha preso spunto la wave che ha avuto il picco di popolarità nel 2021-2022 – tra Bored Apes e CryptoPunks – feel old yet?
Delirio totale. I presenti non hanno mai visto una cosa simile: il gioco funziona su blockchain e, come se non bastasse, l’interfaccia è estremamente user-friendly. Nell’aria la FOMO si può toccare con mano.
Un mese dopo, i CryptoKitties vengono ufficialmente lanciati su Ethereum: una settimana dopo sono stati spesi circa 4,5 milioni di dollari su questi NFT, con un incremento sei volte maggiore delle transazioni in pending. Due settimane dopo il gioco supera i 150mila utenti registrati, con più di 260mila CriptoGatti “adottati” e un giro di soldi pari a 15 milioni di dollari. A un mese dal lancio, le transazioni legate alla compravendita di CryptoKitties rappresentano il 13% di tutte le transazioni su Ethereum. Qui, però, cominciano i problemi.
Con tutta questa attività, il network di Ethereum comincia a rallentare fino a congestionarsi: le transazioni sono aumentate a dismisura e, con esse, le gas fees. La viralità dei CryptoKitties, infatti, ha fatto emergere un problema fondamentale costitutivo della blockchain: la scalabilità. Grazie a questo episodio, gli sviluppatori sono riusciti a comprendere quanto fosse necessario attivarsi per evitare situazioni del genere in futuro.
DeFi Summer: quando la DeFi è diventata la… DeFi
Facciamo un salto di tre anni, dal 2017 al 2020. Non che in quel periodo non sia successo niente, anzi: escono degli aggiornamenti di sistema, tra cui Byzantium e Constantinople, che migliorano notevolmente le performance e, in generale, la rete. Nel 2020, però, succede qualcosa di straordinario che passerà alla storia come la DeFi Summer.
Una breve premessa. La DeFi su Ethereum già esisteva e girava principalmente intorno a tre elementi: gli NFT, i protocolli di lend and borrow e gli exchange decentralizzati (DEX). Del primo dei tre abbiamo già parlato abbondantemente coi CryptoKitties.
Per quanto riguarda il lend and borrow, impossibile non menzionare MakerDAO, un protocollo attivo già dal 2017 attraverso cui gli utenti potevano prendere in prestito varie crypto o guadagnare interessi depositandole. Infine, uno fra i primi DEX lanciati sulla DeFi di Ethereum era EtherDelta, che però ha avuto un tragico epilogo: hack subito nel 2017 e founder condannato per gestione di exchange non autorizzato nel 2018 – in quello stesso anno verrà lanciato Uniswap.
Torniamo al 2020. Fino a quel momento, come abbiamo visto, la DeFi era già realtà e faceva anche numeri interessanti: il TVL (Total Value Locked) su Ethereum oscillava fra i 400 e i 700 milioni di dollari. Verso febbraio 2020, però qualcosa inizia a muoversi. I protocolli già operativi, come Uniswap, Compound e Synthetix, iniziano a migliorare nettamente, arriva anche Yearn.finance e sempre più persone si avvicinano a questo mondo, desiderose di mettere a rendita le proprie crypto.
Il 15 febbraio 2020 il TVL supera il miliardo di dollari. Ma poi arriva il COVID. Il cigno nero genera il panico totale e, di conseguenza, il crash della DeFi. In un mese, il TVL si dimezza, arrivando a toccare quota 400 milioni di dollari.
Col COVID, però, si sono verificate anche due cose particolari: il lockdown e gli aiuti di stato – leggi liquidità – per sopravvivere all’emergenza. Questo significa che, improvvisamente, un grandissimo numero di persone si è ritrovato ad avere un’enorme quantità di tempo libero e un bel po’ di soldi in tasca da spendere. La DeFi, così come il mercato crypto e quello finanziario, recupera immediatamente e parte verso la Luna: signore e signori, via alla DeFi Summer!
A metà maggio, il TVL torna ai livelli del febbraio 2020. A metà giugno, supera il miliardo di dollari. A metà luglio, sfonda il tetto dei 2 miliardi. Ormai l’afflusso di denaro nella DeFi sembra inarrestabile. Il 14 agosto, il TVL su Ethereum raggiunge i 4,5 miliardi. Il giorno dopo, il 15 agosto, siamo a 5,5 miliardi! Un miliardo in un giorno! Tra settembre e ottobre 2020 c’è una leggera flessione, naturale, ma a novembre 2020 i miliardi diventano 11. È solo la prima parte di un viaggio che culminerà un anno dopo, nel novembre 2021, con un TVL pari a 107 miliardi di dollari.
The Merge: il 15 settembre 2022 cambia il meccanismo di consenso
Il Merge – letteralmente “fusione” – è un evento di enorme rilevanza per la storia di Ethereum e della blockchain in generale: si tratta, appunto, della fusione di due chain parallele – la mainnet, cioè quella principale, e la Beacon, quella di test – finalizzata al passaggio dal Proof-of-Work (PoW) a Proof-of-Stake (PoS). Parliamo quindi di un cambiamento radicale del meccanismo di consenso e, di conseguenza, della natura stessa del protocollo.
L’idea non era una cosa dell’ultimo momento, dato che Vitalik aveva già proposto la transizione a PoS nel 2016. Tuttavia, avviene solamente 6 anni dopo, a seguito di ben due anni di esperimenti sulla Beacon chain, la test-net parallela.
L’esigenza di un meccanismo PoS era fondamentalmente legato a due ragioni: ridurre l’impatto ambientale, anche per una questione di regolamentazione e potenziali seccature, e aumentare la scalabilità, che la forma PoW limitava a 15 transazioni al secondo. Il 15 settembre 2022, finalmente, si entra in una nuova era: in corrispondenza del blocco 15.537.393, Ethereum diventa ufficialmente una chain basata su consenso Proof-of-Stake.
Il Merge ha avuto un impatto considerevole sul consumo energetico, drasticamente ridotto del 99,9%; sulla scalabilità, con implementazione di soluzioni Layer-2 e aumento potenziale a 100.000 transazioni al secondo; sulla natura del token ETH, adesso più soggetto a deflazione (gli ETH delle gas fee ora vengono bruciati e non dati ai miner), e sulla sua valutazione, per via di tutto ciò che abbiamo detto finora.
BlackRock ha deciso: Ethereum è la chain giusta
Nel marzo 2024 BlackRock, uno dei fondi di investimento più grandi al mondo, lancia il suo primo fondo tokenizzato e sceglie proprio Ethereum. Si tratta di un evento importantissimo per la storia della blockchain: i grandi player istituzionali hanno capito che il futuro della finanza passa anche da lì. Il fondo ha un nome particolare: BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, o BUIDL. Un meme che diventa realtà – un po’ come il Department Of Government Efficiecy, o DOGE, di Elon Musk.
Il fondo, fermo a quota 500 milioni per mesi, ha visto una crescita incredibile a partire da marzo 2025: in due mesi, il TVL si è sestuplicato, arrivando a toccare quota 3 miliardi di dollari. Al momento in cui scriviamo, BUIDL si aggira sui 2,39 miliardi, di cui 2,16 bloccati su Ethereum (più del 90%), 68,5 milioni sulla rete di Polygon e 53,9 milioni su Aptos.
La SEC approva gli ETF Spot su Ethereum
Dopo l’approvazione degli ETF Spot su Bitcoin, è il turno di quelli su Ethereum: il 23 maggio 2024 la SEC (Securities and Exchange Commission) dà il via libera a nove ETF tematici su ETH, che vengono lanciati ufficialmente sul mercato due mesi dopo, il 23 luglio. Tra gli emittenti troviamo ovviamente BlackRock, Van Eck, Digital Currency Group (Grayscale), FMR LLC (Fidelity) e Invesco.
Si tratta di un passo importantissimo che testimonia l’interesse istituzionale per ETH come asset e che, di conseguenza, legittima ancora di più l’universo che ruota intorno alla blockchain e alle criptovalute. Al momento in cui scriviamo, gli ETF Spot su Ethereum hanno raccolto un totale di 16,7 miliardi di dollari in AUM (Asset Under Management). Per dare un metro di paragone, gli ETF Spot su Bitcoin si attestano intorno ai 151 miliardi di dollari – quasi dieci volte tanto.
Il nostro modo di festeggiare i dieci anni di Ethereum
Noi di Young Platform abbiamo particolarmente a cuore Ethereum, dato che il nostro token YOUNG (YNG) è costruito proprio su Ethereum secondo lo standard ERC-20. Inoltre, nel caso non ti fosse arrivata la notizia, dal 17 luglio YNG è ufficialmente disponibile su Uniswap e tracciabile su Coinmarketcap e Dexscreener.
Per questi motivi, solo per oggi sulla nostra app sarà disponibile una missione a tema Ethereum che ti permetterà di guadagnare delle gemme, cuore pulsante del nostro concorso a premi The Unbox. Nel link trovi tutte le informazioni necessarie per provare a vincere ricompense incredibili: se al nono posto si vincono le Airpods Max, riesci a immaginare cosa abbiamo pensato per il primo posto? Se non l’avessi ancora fatto, ti consigliamo di dare un’occhiata – e partecipare!
Ricordati di iscriverti al nostro canale Telegram e a Young Platform cliccando qui sotto!
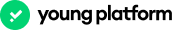
Acquista ETH su Young Platform