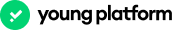La povertà è un problema reale che colpisce milioni di persone nel mondo: cosa è stato fatto finora per arginarla? Con quali esiti? Si può fare altro?
La povertà viene definita in base a una soglia, detta appunto “soglia di povertà”, che la Banca Mondiale determina a 3$ al giorno: sulla base di questo criterio, circa 808 milioni di persone nel mondo vivono in condizioni di vero disagio economico, nonostante nel tempo la situazione sia notevolmente migliorata. Sono molte, infatti, le soluzioni messe in campo negli anni per cercare di risolvere questo problema. Gli sforzi sono bastati? Si può fare altro?
Povertà: definizione
La povertà, secondo la Banca Mondiale, è la “deprivazione marcata del benessere”: in questo senso, sono considerati poveri coloro che non dispongono del reddito necessario per acquistare un “paniere minimo” di beni di consumo socialmente accettato. In altre parole, vivono in uno stato di povertà coloro che non possiedono risorse monetarie sufficienti per superare una soglia minima ritenuta adeguata, chiamata appunto soglia di povertà.
Una definizione più ampia di povertà – e quindi benessere – si concentra su un criterio in particolare: la capacità dell’individuo di vivere e, in generale, “funzionare bene” all’interno della società. In questo modo, la povertà viene calcolata anche in base all’accesso all’educazione, alla sanità, alla libertà d’espressione e così via.
Tornando al concetto di soglia di povertà, la Banca Mondiale quantifica questo limite in due modi, ovvero relativo e assoluto: se il primo prende in considerazione caso per caso, individuando una cifra in dollari in base alle caratteristiche di quel Paese, il secondo determina un valore universale.
La soglia di povertà varia periodicamente al variare delle condizioni macroeconomiche. Nel 1990, al momento della sua introduzione, la soglia assoluta era fissata a 1$ al giorno per i paesi a basso reddito, mentre a giugno 2025, in occasione dell’ultimo aggiornamento, è stata alzata a 3$ al giorno.
Quali sono le cause della povertà?
La povertà – per dire una cosa non banale e poco retorica – è un concetto complesso, frutto dell’interazione di più cause. In ogni caso, l’EAPN (European Anti-Poverty Network) identifica alcuni fattori chiave: bassi livelli di istruzione, alta disoccupazione e forte presenza di lavori sottopagati, assenza di un Welfare State che possa aiutare chi è in difficoltà, per citarne alcuni.
Si tratta, evidentemente, di elementi che sono allo stesso tempo causa e conseguenza. Semplificando all’estremo: uno Stato povero, per “restare in piedi” e non fallire, probabilmente sarà costretto a tagliare la spesa sociale e gli investimenti, creando le condizioni per una bassa scolarizzazione e un’alta disoccupazione le quali, a loro volta, impediranno ai cittadini di istruirsi e accedere a lavori con salari più alti. I consumi interni crollano, l’economia non cresce e lo Stato si impoverisce ulteriormente e taglia la spesa sociale… eccetera eccetera.
Esiste, però, un indicatore che, più di altri, correla positivamente con la povertà di un Paese: quando l’uno sale, l’altra sale e viceversa. Parliamo del debito estero, cioè quella parte di debito detenuto da creditori non residenti nel dato paese, che include sia il debito pubblico estero sia il debito privato estero.
Il primo è composto da obbligazioni e titoli di stato – dunque strumenti finanziari emessi dallo stato – detenuti da investitori stranieri; il secondo, invece, è il debito che i soggetti privati, come aziende e banche, accumulano nei confronti di soggetti esterni.
Perchè il debito estero ha un ruolo così importante?
La povertà, come abbiamo appena scritto, è correlata col debito estero, dal momento che l’una è alta laddove l’altro è alto. Il motivo, fondamentalmente, è sintetizzabile in due parole: il peccato originale, cioè l’impossibilità per un Paese LIC (Low Income Country, a basso reddito) di emettere debito verso investitori esteri in valuta nazionale, con tutte le ripercussioni del caso che affronteremo a breve.
Il termine, preso in prestito dal Cristianesimo, gioca proprio sull’analogia religiosa: così come l’essere umano nasce ereditando la condizione di peccato di Adamo, allo stesso modo i Paesi LIC “nascono già colpevoli” ereditando delle difficoltà strutturali che non dipendono dalle politiche attuate, ma dal sistema finanziario globale che non si fida della loro valuta.
Il peccato originale, il mismatch valutario e le sue conseguenze
Questo è il fulcro della questione: mentre i Paesi ad alto reddito, come il Regno Unito, possono distribuire gran parte del proprio debito in valuta nazionale, cioè la sterlina, i Paesi LIC sono costretti a ricorrere a valute estere forti, come il dollaro, l’euro o lo yen. Ciò produce il cosiddetto mismatch valutario, ovvero la differenza tra la valuta in cui un Paese emette debito e quella in cui genera reddito, con tutti gli effetti negativi che ne conseguono.
Immagina di voler finanziare con 1.000$ il debito del Madagascar, un Paese LIC con alto debito estero, acquistando un titolo di Stato a 3 anni. Il Tesoro malgascio, a questo punto, ti propone due soluzioni: puoi comprare direttamente i bond in dollari, sapendo che il rimborso con gli interessi avverrà in dollari, o puoi convertire i 1000 dollari in 4.487.736 ariary (la valuta locale), con relativo rimborso – fra tre anni – in ariary. Il problema è che il Madagascar ha un’inflazione molto alta. È chiaro, quindi, che sceglierai la prima opzione.
Il Madagascar, pertanto, ha pochissime possibilità di emettere debito in ariary, perché realisticamente qualsiasi investitore, come te, preferirà il dollaro. Ecco servito il mismatch valutario: il debito estero e gli interessi – molto alti per i Paesi LIC – sono in dollari, mentre le entrate dello stato sono in valuta locale: se il tasso di cambio col dollaro resta stabile, il problema non si pone. Sfortunatamente, non è questo il caso del Madagascar: nel 2017, il tasso di conversione dollaro/ariary era di 1 a 3.000, oggi è 1 a 4.488.
Il mismatch valutario è deleterio perché amplifica nettamente gli shock. Immaginiamo uno scenario in cui il Madagascar viene colpito da una crisi endogena, come un colpo di stato, o esogena, come una catastrofe naturale: la fuga di capitali dal Paese è praticamente garantita, poiché qualunque investitore cercherebbe di preservarsi rifugiandosi in asset più solidi. Il risultato? La valuta, già molto debole, si svaluterebbe ancora di più, con conseguente drastico aumento del costo del servizio del debito – l’importo totale che lo Stato deve pagare agli investitori. La conseguenza? Crisi di liquidità e probabile default.
La compressione della spesa sociale
Shock a parte, il peccato originale limita notevolmente il margine di spesa di uno Stato come il Madagascar per un paradosso che Marco Zupi, analista geopolitico e autore di un articolo proprio sul tema della sostenibilità del debito, chiama “doppia verità”: nonostante il peso del debito pubblico sia spesso maggiore nelle economie avanzate, i Paesi LIC devono fare i conti con un carico relativo del debito sproporzionatamente più alto.
In parole semplici, anche se il Madagascar detiene un debito pubblico sensibilmente più basso di quello italiano, si trova a pagare un costo relativo molto più alto e deve usare una fetta sproporzionata delle sue scarse entrate solo per pagarne gli interessi. Questi, infatti, sono alti sia perchè gli investitori, dato il rischio, richiedono premi adeguati, sia perchè, come abbiamo visto, l’inflazione dello stato africano svaluta notevolmente l’ariary malgascio. Tutto questo porta alla compressione della spesa sociale, ovvero al taglio dei finanziamenti all’istruzione, alle opere pubbliche, alla sanità e così via.
Restando sul tema, l’indebitamento degli stati africani, come scrive Zupi, ha toccato il punto più alto dell’ultimo decennio nel 2023, con un rapporto debito/PIL pari al 61,9%. In generale, nel 2024, i paesi in via di sviluppo hanno speso, mediamente, il 15% delle entrate pubbliche per il pagamento del debito estero, con un aumento del 6,6% rispetto al 2010. Tutto ciò, come abbiamo spiegato poco sopra, riduce la possibilità per un Paese LIC di investire nel welfare, ai danni dei suoi cittadini: ad esempio, in almeno 34 Paesi africani, la spesa per il pagamento del debito estero è più alta di quella per l’istruzione e la sanità – nel triennio 2021-2023, questa è stata rispettivamente di 70, 63 e 44 dollari pro capite. Anche a livello mondiale, quasi 3,4 miliardi di persone vivono oggi in Paesi costretti a indirizzare la spesa pubblica in questo modo.
Le iniziative per la riduzione del debito nei Paesi LIC
La comunità internazionale, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si è mossa per cercare di arginare questo fenomeno, evidentemente con scarsi risultati. Nello specifico, sono sei le iniziative messe in campo per ridurre la dipendenza dei Paesi LIC dal debito e consentirgli uno sviluppo più organico e sano. Vediamole rapidamente i progetti e perché non hanno funzionato.
Piano Baker (1985-1988)
Col Piano Baker, in due parole, si è privilegiata la liquidità, inondando i Paesi in difficoltà con nuovi capitali a prestito. La strategia era mossa dalla convinzione che questi Stati fossero solamente illiquidi, cioè temporaneamente senza denaro a sufficienza per ripagare il debito.
In realtà, la diagnosi era sbagliata: più che di illiquidità, sarebbe stato opportuno parlare di insolvenza strutturale, ovvero dell’impossibilità di ripagare un debito – perché troppo alto – anche nel lungo periodo.
Il Piano Baker, quindi, ha “fornito ossigeno” e ha evitato crisi sistemiche nel breve termine, senza però affrontare la criticità alla base. In sintesi, ha rinviato il problema senza risolverlo.
Piano Brady (1989 in poi)
La conseguenza del fallimento del Piano Baker: la comunità internazionale ha riconosciuto che l’ostacolo principale non fosse la mancanza di liquidità, ma l’ampiezza del debito e la relativa insolvenza strutturale. C’era un altro problema da risolvere: i prestiti bancari del Piano Baker, ormai, erano diventati inesigibili, cioè spazzatura, dal momento che nessuno stato avrebbe mai onorato il debito. Che fare?
I prestiti bancari vengono convertiti in titoli garantiti da collaterali forti – come i Titoli del Tesoro USA, uno degli investimenti più sicuri al mondo – chiamati, appunto, i Brady Bond. Ma a una condizione. Semplificando, il Piano Brady dice alle banche: “il tuo prestito da 10 miliardi non vale nulla, ma ora potrai scambiarlo con un Brady Bond da 7 miliardi”. Naturalmente, le banche accettano, perché perdere il 30% dell’investimento è meglio che perdere il 100%, e il debito viene scontato – non più 10 ma 7 miliardi da rimborsare.
L’obiettivo era riaprire l’accesso al mercato ai Paesi LIC tramite i Brady Bond garantiti, che riducevano il debito e, ovviamente, risultavano molto più appetibili agli occhi degli investitori rispetto ai vecchi prestiti-spazzatura.
Tuttavia, l’entità delle riduzioni era limitata e insufficiente a rendere sostenibile il debito: per riprendere il nostro esempio inventato, lo sconto da 10 a 7 miliardi era inutile per uno Stato che non poteva rimborsarne neanche 5.
Heavily Indebted Poor Countries e Multilateral Debt Relief Initiative (1996 – 2005)
Anche queste due iniziative, che chiameremo rispettivamente HIPC e MDRI, nascono in risposta al fallimento del piano precedente e, secondo gli esperti, hanno rappresentato il tentativo più ambizioso di sempre per ridurre il debito estero dei Paesi LIC.
Dunque, dopo aver imparato la lezione dei Piani Baker e Brady, la comunità internazionale è intervenuta direttamente sul debito: con l’HIPC, si sono verificati tagli fino al 90% delle passività, mentre con la MDRI si è arrivati a cancellare il 100% del debito dei Paesi LIC nei confronti di istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
Finalmente, veniva effettivamente liberato lo spazio fiscale e i Paesi a basso reddito potevano utilizzare il capitale in avanzo – che poco prima era destinato al pagamento di interessi e titoli – per la spesa sociale: “in Tanzania e Uganda”, come scrive Marco Zupi, “la spesa per l’istruzione e per la sanità è aumentata significativamente dopo la cancellazione del debito”.
Cosa non ha funzionato? Per riassumere, l’HIPC e la MDRI hanno risolto parte dei problemi del passato dal momento che, secondo la Banca Mondiale, ben 37 Paesi avrebbero beneficiato di più di 100 miliardi di dollari di “sconto”. Queste iniziative, tuttavia, hanno fallito nel prevenire le crisi future: tralasciando l’imposizione di condizioni abbastanza rigide per ottenere i finanziamenti, non è stato realizzato nè pensato alcun intervento mirato alla riforma del sistema, lasciando intatte quelle difficoltà strutturali alla base dei “peccato originale” dei Paesi LIC e di tutto ciò che ne consegue. Questi Paesi, come per certezza matematica, hanno ricominciato ad accumulare debito su debito.
Ma non è tutto! Siamo nel terzo millennio, il mondo sta cambiando e nuovi protagonisti stanno emergendo. Questo per dire che, se i “vecchi debiti” venivano contratti principalmente verso gli Stati membri del Club di Parigi – tra cui USA, UK, Italia, Germania, Giappone e Canada – e banche multilaterali come la Banca Mondiale, adesso abbiamo una sfilza di nuovi creditori: dagli Stati non membri del Club di Parigi come la Cina, ai creditori privati come i fondi di investimento e banche commerciali.
In sintesi, il nuovo ordine di creditori ha contribuito – e contribuisce tuttora – a rendere le varie crisi molto più complesse: se prima esisteva un tavolo unico – il Club di Parigi – che organizzava e portava avanti le negoziazioni, adesso lo scenario è molto più frammentato e difficile da coordinare.
Debt Service Suspension Initiative (2020-2021)
Il DSSI è stata un’iniziativa lanciata dal G20 – le 20 maggiori economie del mondo – durante la pandemia da Covid-19. Come è facilmente intuibile dal nome, il DSSI nasce con l’obiettivo di mettere temporaneamente in pausa i pagamenti del debito: si è trattato di uno sospensione di circa 13 miliardi di dollari in versamenti per 48 Paesi, che hanno quindi avuto maggiore disponibilità per combattere la crisi sanitaria.
Il DSSI, a livello di logiche di fondo, è molto simile al Piano Baker, dal momento che entrambi i programmi si sono focalizzati sulla liquidità e non sulla solvibilità, avendo concentrato gli interventi sul sollievo temporaneo piuttosto che sui deficit strutturali. L’unica vera differenza sta nelle modalità attraverso cui si è arrivati all’obiettivo: col Piano Baker si concedevano prestiti bancari, mentre col DSSI si è semplicemente permessa l’interruzione dei pagamenti.
Come per le logiche, le due iniziative si somigliano anche per i limiti, nel senso che nella progettazione del DSSI non è stata pianificata alcuna strategia a lungo termine – ma va considerato il contesto emergenziale in cui prende piede. In questo caso, però, si è verificato un effetto collaterale che l’autore dell’articolo sulla sostenibilità del debito (Marco Zupi) ha definito “perverso”.
Lo stop ai pagamenti, infatti, ha riguardato solamente i “creditori ufficiali”, ovvero gli Stati membri del Club di Parigi, senza toccare i creditori privati: banche e fondi di investimento hanno continuato a ricevere i corrispettivi dovuti.
Common Framework (2020 – presente)
È l’iniziativa attuale messa in campo dal G20 ed ha molti punti in comune con l’HIPC e il MDRI: anche il Common Framework (CF) è stato pensato per affrontare la questione alla radice, andando ad intervenire sulla solvibilità dei Paesi, dunque sulla riduzione dello stock di debito totale a un livello sostenibile.
Essendo il CF in corso d’opera, è difficile dare un giudizio sulla sua efficacia. Le critiche principali, tuttavia, fanno riferimento alla lentezza delle procedure che caratterizza il programma. In due parole, citando l’autore, “gli sconti, quando arrivano, lo fanno tardi e spesso dopo costosi periodi di incertezza”. Inoltre, c’è anche un nodo da sciogliere relativo al coinvolgimento dei privati i quali, a causa dell’inattrattività degli incentivi, decidono di non partecipare.
Come si evolverà la situazione?
È chiaramente una domanda retorica a cui nessuno può dare una risposta certa: anche le iniziative descritte finora, che pure erano motivate da una (apparente?) solidarietà di fondo, hanno in parte fallito nel loro intento, a testimonianza della complessità strutturale che contraddistingue il sistema finanziario.
Nel frattempo, è possibile ragionare su alcune soluzioni che, nell’immediato, potrebbero offrire una sorta di strumento di autodifesa finanziaria alle vittime di questo sistema. Torniamo al caso del Madagascar: i suoi abitanti, dal 2017, hanno visto l’ariary, la valuta locale, svalutarsi del 50%. Come mettere un freno all’inflazione?
Povertà e il ruolo delle criptovalute
Partiamo con una premessa: secondo il Global Findex 2025 pubblicato dalla Banca Mondiale, quasi un miliardo e mezzo di persone nel mondo sono unbanked, cioè non possiedono un conto corrente. Allo stesso tempo, sempre secondo lo stesso report, l’86% degli adulti possiede un telefono cellulare – la percentuale scende all’84% nei Paesi LIC. Infine, incrociando i dati, il 42% degli adulti unbanked possiede uno smartphone.
Il punto fondamentale è che esiste una vastissima parte della popolazione mondiale senza accesso finanziario che però possiede già l’infrastruttura di base, ovvero telefono e connessione a internet, per poter risolvere il problema – detto parafrasando un proverbio, “hanno i denti ma non il pane”.
Uno smartphone connesso ad internet, per esempio, è quanto basta per poter installare un wallet e comprare, vendere, inviare e ricevere le criptovalute – e finalmente utilizzare i denti per mangiare il pane. Ma perché le criptovalute potrebbero rappresentare un freno per l’inflazione? Continuiamo con l’esempio del nostro adorato Madagascar.
Caso 1: King Julien XIII compra le crypto
Abbiamo quindi un abitante unbanked di Antananarivo, capitale del Madagascar, che possiede solo uno smartphone su cui ha installato un wallet crypto. Il nostro abitante, che chiameremo King Julien, in onore del film Madagascar, vuole convertire i suoi ariary in Bitcoin o stablecoin – come USDC – perché si è stufato di vedere il suo capitale diminuire giorno dopo giorno a causa dell’inflazione. Per prima cosa, King Julien deve superare l’ostacolo più grande: essendo unbanked, deve trovare un modo per digitalizzare i suoi contanti.
Nell’Africa Sub-sahariana, dal momento che in molti fanno i conti con lo stesso impedimento di King Julien, esiste una soluzione diffusissima: il Mobile Money, un servizio finanziario che permette di ricevere, inviare e conservare denaro attraverso la SIM dello smartphone.
King Julien, quindi, si reca in uno dei tanti negozi di telefonia in giro per Antananarivo, consegna i suoi ariary cash e riceve l’equivalente – meno una commissione – sul suo conto di Mobile Money. Ricordiamo che King Julien, nonostante abbia dei soldi digitali, è ancora unbanked, cioè sprovvisto di conto corrente presso una banca. Per questo motivo, non può utilizzare un exchange.
King Julien sceglie un’altra via e accede a una piattaforma peer-to-peer (P2P) per cercare un venditore che accetti il suo metodo di pagamento. Una volta trovato, avviene la transazione: non appena il venditore conferma di aver ricevuto il pagamento, sblocca i Bitcoin o gli USDC – precedentemente bloccati nell’escrow, un deposito di garanzia – che la piattaforma poi trasferisce al wallet crypto dell’acquirente.
King Julien, adesso, è sicuro che il suo capitale non si svaluterà come avveniva in precedenza con l’ariary. Per spendere i soldi, dunque convertire Bitcoin o USDC in ariary, gli basterà effettuare il processo inverso.
Caso 2: King Julien riceve crypto dall’estero
Per concludere, vediamo un altro caso: King Julien riceve le crypto da un parente emigrato In Italia dove, al 1 gennaio 2024, la popolazione malgascia residente è pari a 1,675 unità. King Julien, come abbiamo visto, è unbanked e non può ricevere un bonifico. Ma anche qui le crypto ci vengono in soccorso, con un procedimento più rapido rispetto al Caso 1.
Il parente, tramite Young Platform, converte i suoi euro in Bitcoin o USDC in un secondo e li invia al wallet di King Julien, che potrà riconvertirli in ariary attraverso il procedimento inverso che abbiamo menzionato poco fa. Pure stavolta, King Julien è riuscito a mettere in salvo il suo capitale dall’inflazione.
Il problema non è risolto, ma King Julien vive meglio
Per concludere, una breve riflessione: è chiaro che in questo modo non si risolve il nodo della povertà, che resta una questione prioritaria nell’agenda internazionale. Tuttavia, una soluzione come quella appena esposta può aiutare molto gli abitanti dei Paesi LIC. Almeno quelli con un telefono.
Iscriviti al nostro canale Telegram e a Young Platform per non perderti altri approfondimenti e, in generale, le notizie che contano!
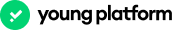
Registrati su Young Platform!